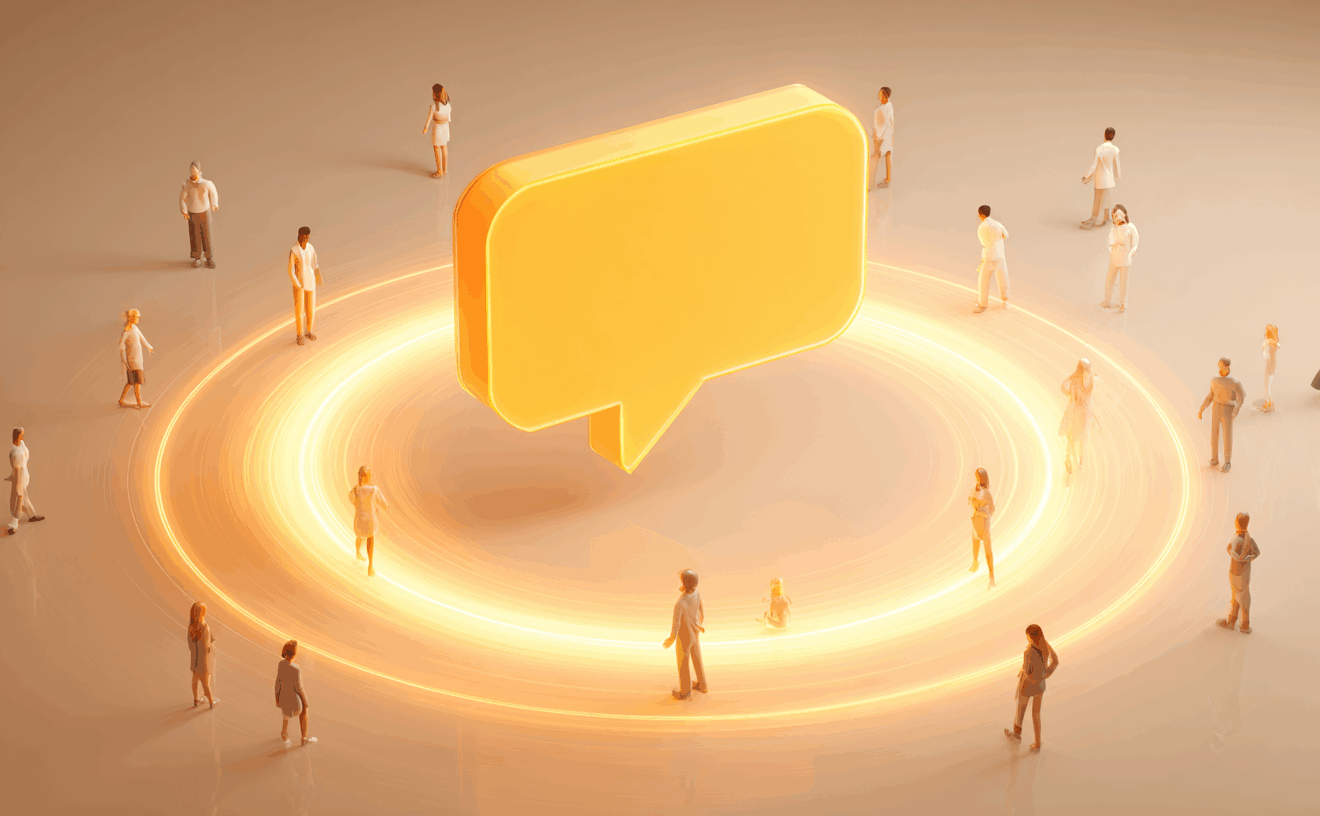Abstract
Nell’era dei social media e dell’iperconnessione, il lettore non si limita più ad assorbire contenuti: interpreta, giudica, risponde. Questo articolo esplora perché la ricezione attiva non è solo un fenomeno culturale, ma una realtà concreta con cui devono fare i conti imprese, professionisti e PMI.
Il significato di un messaggio, infatti, cambia nel momento stesso in cui viene recepito. A partire dalle teorie di Stuart Hall e Umberto Eco, analizziamo perché coinvolgere davvero il pubblico – e non solo “raggiungerlo” – sia oggi una condizione indispensabile per essere ascoltati.
Un lettore attivo può trasformarsi nel tuo miglior alleato. Oppure nella voce più potente della tua crisi reputazionale.
Perché il lettore non è mai neutrale?
Nel mondo della comunicazione, si è a lungo creduto che il messaggio viaggiasse in modo diretto dal mittente al destinatario, come una lettera chiusa spedita da una persona a un’altra. In questa visione, chi riceve il messaggio avrebbe solo il compito di aprirlo e leggerlo, senza alterarne il senso. Ma le cose non funzionano davvero così.
Ogni volta che una persona legge un testo – che si tratti di un articolo, di una campagna pubblicitaria o di un post sui social – non si limita ad assorbire ciò che legge. Interpreta. E interpreta a modo suo. Questo significa che non esiste un lettore “neutro” o “passivo”, perché chi legge è sempre attivo nel dare un significato a ciò che riceve.
A spiegare bene questo concetto è stato, già negli anni ’70, Stuart Hall, uno dei più importanti studiosi di comunicazione del XX secolo. Stuart Hall era un sociologo giamaicano-britannico, noto per aver fondato il cosiddetto “approccio culturale” allo studio dei media. Nel suo saggio Encoding/Decoding (1980), Hall afferma che il significato di un messaggio non è fisso, ma si costruisce nel momento in cui il pubblico lo riceve.
Secondo Hall, chi produce un contenuto “codifica” un messaggio con una certa intenzione. Ma chi lo riceve può “decodificarlo” in modi diversi. Ci sono tre possibilità:
- il pubblico può accettare pienamente il messaggio come l’autore lo aveva pensato (lettura dominante);
- può accettarlo in parte e adattarlo alla propria esperienza (lettura negoziata);
- oppure può rifiutarlo e reinterpretarlo in modo opposto (lettura oppositiva).
Una riflessione molto simile arriva anche da un autore italiano: Umberto Eco, studioso di semiotica (la disciplina che studia i segni e i significati). Nel suo libro Lector in fabula (1979), Eco dice che un testo non è un contenitore chiuso pieno di significati già pronti, ma una “macchina pigra”: funziona solo se il lettore ci mette del suo per farla partire. E per farla partire, ogni lettore attinge alla propria “enciclopedia” personale – una raccolta fatta di conoscenze, esperienze, emozioni, riferimenti culturali. È come se ogni persona leggesse con un bagaglio diverso sulle spalle. E questo bagaglio cambia completamente l’interpretazione.
Ecco perché la comunicazione non è mai un processo lineare. Non basta “scrivere bene” o “parlare chiaro” per essere certi che il messaggio venga compreso così come lo si era immaginato. Chi legge porta sempre con sé un punto di vista, e questo punto di vista ha un peso reale nella costruzione del significato finale.
Cosa succede quando il messaggio non viene recepito come previsto?
Molte aziende, quando comunicano con il pubblico, partono da un presupposto che può rivelarsi pericoloso: credono di avere il controllo totale sul messaggio. Pensano che basti scegliere bene le parole, curare il tono e rispettare il piano editoriale per ottenere una risposta prevedibile, coerente con le intenzioni iniziali. Ma, come abbiamo visto, il lettore non è un ricettore passivo. E questo cambia tutto.
Chi comunica deve fare i conti con una verità scomoda ma inevitabile: non è detto che il messaggio arrivi “come previsto”. Anzi, succede spesso che venga reinterpretato, modificato o addirittura ribaltato dal pubblico. Quando ciò accade, il significato originario può trasformarsi in qualcosa di molto diverso, perfino opposto.
Per esempio, negli ultimi anni ci sono stati diversi casi in cui campagne pubblicitarie ben intenzionate si sono ritorte contro chi le aveva lanciate. Il motivo? Il pubblico – attivo, connesso e critico – ha dato al messaggio un’interpretazione completamente diversa.
Il caso Bud Light (2023)
Un esempio clamoroso è quello di Bud Light, che nel 2023 aveva scelto di collaborare con l’influencer transgender Dylan Mulvaney per una campagna volta a rafforzare l’immagine del marchio presso un pubblico giovane e inclusivo. L’iniziativa, pensata per promuovere diversità e rappresentanza, è stata invece accolta con fortissime critiche da parte di ambienti conservatori, generando boicottaggi, cali di vendite e una crisi reputazionale amplificata dai media statunitensi (si v. La campagna di Bud Light con Dylan Mulvaney).
Deliveroo e la falsa personalizzazione (2024)
Un altro episodio significativo è quello di Deliveroo, che nel Regno Unito aveva organizzato uno stunt pubblicitario per San Valentino inviando ai clienti delle lettere dall’aspetto di biglietti d’amore scritti a mano. L’idea era quella di sorprendere e divertire, ma molti destinatari si sono sentiti ingannati, convinti di aver ricevuto messaggi personali da ammiratori anonimi. L’effetto è stato l’opposto: disillusione, critiche sui social e accuse di marketing ingannevole, tanto da costringere l’azienda a scusarsi pubblicamente (si v. Deliveroo apologises for ‘misjudged’ Valentine’s Day marketing stunt).
American Eagle e il doppio senso “genes/jeans” (2025)
Più recentemente, il brand di abbigliamento American Eagle ha lanciato una campagna con l’attrice Sydney Sweeney, giocata sullo slogan “Great Jeans / Great Genes”. L’intenzione era ironica e leggera, ma molti utenti hanno interpretato il messaggio come un richiamo implicito a standard estetici esclusivi e a connotazioni razziali legate all’idea di “buoni geni”. Le polemiche hanno spinto il marchio a difendersi, sottolineando l’innocuità dell’intento creativo (si v. American Eagle’s ‘good jeans’ ads).
Questi episodi non sono casi isolati. Mostrano un principio fondamentale della comunicazione contemporanea: il significato finale di un messaggio non lo decide chi lo scrive, ma chi lo riceve.
Per chi lavora nella comunicazione d’impresa, questo comporta una sfida: non basta pensare a ciò che si vuole dire. Bisogna anche prevedere come il messaggio potrà essere percepito, alla luce dei valori, delle emozioni e delle aspettative del pubblico. Soprattutto in un contesto digitale, dove ogni lettore ha la possibilità di reagire in tempo reale – commentare, condividere, criticare – il messaggio non viaggia in un canale chiuso, ma entra in una piazza pubblica, dove può essere discusso, trasformato e persino ridicolizzato.
Questo significa che ignorare il ruolo attivo del destinatario può avere conseguenze serie: fraintendimenti, danni reputazionali, perdita di credibilità.
Come cambia la comunicazione aziendale nell’era dell’engagement?
Nel contesto attuale, l’attenzione del pubblico è una risorsa preziosa e limitata. Ogni giorno, le persone ricevono centinaia di stimoli: notifiche, newsletter, video, post sponsorizzati. Ma solo pochi messaggi riescono davvero a catturare l’interesse del lettore. Questo significa che le imprese non possono più limitarsi a “raggiungere” il pubblico: devono meritare la sua attenzione, coinvolgerlo, stimolarlo a partecipare.
Qui entra in gioco un concetto chiave: l’engagement, cioè il coinvolgimento attivo del destinatario. Non si parla più di audience nel senso tradizionale – una folla silenziosa che ascolta – ma di persone che vogliono interagire, scegliere, contribuire. Il pubblico non accetta più un ruolo passivo: vuole essere parte della conversazione.
Questa trasformazione è confermata anche dalla teoria degli usi e gratificazioni, sviluppata nel campo della comunicazione di massa negli anni sessanta. Secondo questa teoria, il pubblico non si limita a “subire” i contenuti, ma li seleziona consapevolmente per soddisfare bisogni specifici: informarsi, intrattenersi, formarsi, socializzare. Questo approccio mette al centro il lettore come soggetto attivo e strategico.
Nel marketing e nella comunicazione aziendale, ciò si traduce in un cambiamento profondo. Le imprese che vogliono essere ascoltate devono progettare contenuti che favoriscano l’interazione, invece di limitarsi a “comunicare un messaggio”. E infatti, secondo il report Tendenze delle piattaforme di contenuti interattivi 2025-2033, il mercato delle piattaforme che permettono di creare contenuti interattivi — che comprendono quiz, sondaggi, calcolatori — raggiungerà un valore stimato di circa 2 miliardi di dollari nel 2025, con una crescita annua composta prevista del 15% fino al 2033. Aziende di diversi settori stanno adottando questi formati per aumentare il coinvolgimento del pubblico, migliorare la generazione di lead e incrementare i tassi di conversione.
E il motivo è semplice: questi strumenti funzionano. Secondo un articolo di Forbes, i contenuti interattivi generano in media il 52,6% di coinvolgimento in più rispetto a quelli statici (si v. Engage Your Audience With Interactive Content). In altre parole, il pubblico reagisce meglio quando sente di avere un ruolo attivo: non solo legge o guarda, ma partecipa, interagisce, contribuisce a dare senso al contenuto. Questo porta a una percezione più positiva, a un senso di valorizzazione e, di conseguenza, a una maggiore disponibilità a fidarsi del messaggio proposto.
Questa trasformazione non riguarda soltanto il marketing aziendale. Anche i media e il giornalismo hanno adottato un approccio audience-first: ad esempio, Bloomberg Media – la divisione editoriale della multinazionale Bloomberg, leader globale nell’informazione economico-finanziaria – analizza dati e feedback dei lettori per costruire esperienze personalizzate capaci di mantenerne alta l’attenzione (si v. Bloomberg Media).
Abbiamo visto come mettere il lettore al centro non sia più un’opzione, ma una condizione per essere ascoltati. Per le imprese, questo significa cambiare mentalità: non basta più “dire bene”, occorre ascoltare, dialogare, coinvolgere. Chi riesce a costruire questa relazione partecipativa crea un legame più solido, duraturo e profondo con il proprio pubblico. In definitiva, il successo di una comunicazione non si misura più solo in termini di visibilità, ma nella qualità della relazione costruita con chi legge.
Quali opportunità (e rischi) comporta un lettore attivo per le imprese?
Immagina di parlare con un cliente o con un potenziale partner. Ti ascolta con attenzione, prende appunti, ti fa domande, ti chiede chiarimenti. Sarebbe un ottimo segnale, no? Eppure, quando questo stesso comportamento lo troviamo nel pubblico che legge o ascolta i messaggi aziendali, spesso viene visto come un problema. In realtà, un pubblico attivo è un valore enorme, se si sa come gestirlo.
Partiamo dal lato positivo. Un lettore coinvolto è anche un lettore più attento, più fedele e più preparato. Le ricerche sull’apprendimento lo confermano: quando una persona affronta un testo in modo passivo, il ricordo che ne resta è molto limitato — modelli educativi come la Learning Pyramid stimano che si conservi appena il 10% di ciò che si legge. Al contrario, se il lettore viene stimolato a partecipare — attraverso domande, interazioni o collegamenti personali — la capacità di comprendere e ricordare cresce in modo significativo. Uno studio MDPI del 2024, che ha esaminato 64 articoli condotti tra il 2020 e il 2024, segnala che l’uso di tecnologie interattive in corsi universitari online può aumentare la ‘conservazione delle conoscenze’ del 31% rispetto a contesti meno interattivi (si v. Use of Interactive Technologies to Increase Motivation in University Online Courses).
Per un’impresa, questo significa che coinvolgere il destinatario non è solo una questione di stile, ma ha effetti pratici e misurabili: clienti più informati, dipendenti più preparati, relazioni più solide. La comunicazione interattiva può diventare uno strumento di formazione, fidelizzazione e crescita, a patto che venga progettata con attenzione.
Naturalmente, c’è anche l’altro lato della medaglia. Un lettore attivo non accetta qualunque messaggio senza pensarci, ma lo mette alla prova. E questo significa che ogni incongruenza, ogni tono forzato o ogni mancanza di coerenza può essere notata, criticata e condivisa pubblicamente. Soprattutto in un mondo dove ogni lettore è libero di potersi esprimere, attraverso i social, gli errori comunicativi possono amplificarsi velocemente, con danni reputazionali difficili da contenere.
Per questo, comunicare in modo trasparente e autentico non è più solo una scelta etica, ma una strategia di sopravvivenza. La fiducia si conquista dimostrando coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Ma se si è disposti ad accettare il confronto, anche le critiche diventano occasioni per migliorare, innovare, correggere il tiro. Un lettore attento è anche un suggeritore prezioso.
In conclusione, accogliere la ricezione attiva del pubblico non significa perdere il controllo, ma cambiare prospettiva. Significa trattare il lettore come un interlocutore intelligente e capace, con cui costruire una relazione fondata sul rispetto e sulla fiducia. E chi riesce a farlo, non solo comunica meglio: costruisce valore nel tempo.
© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2025
È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Martina Di Molfetta
Laureata in Comunicazione, Innovazione e Multimedialità presso l'Università degli studi di Pavia.