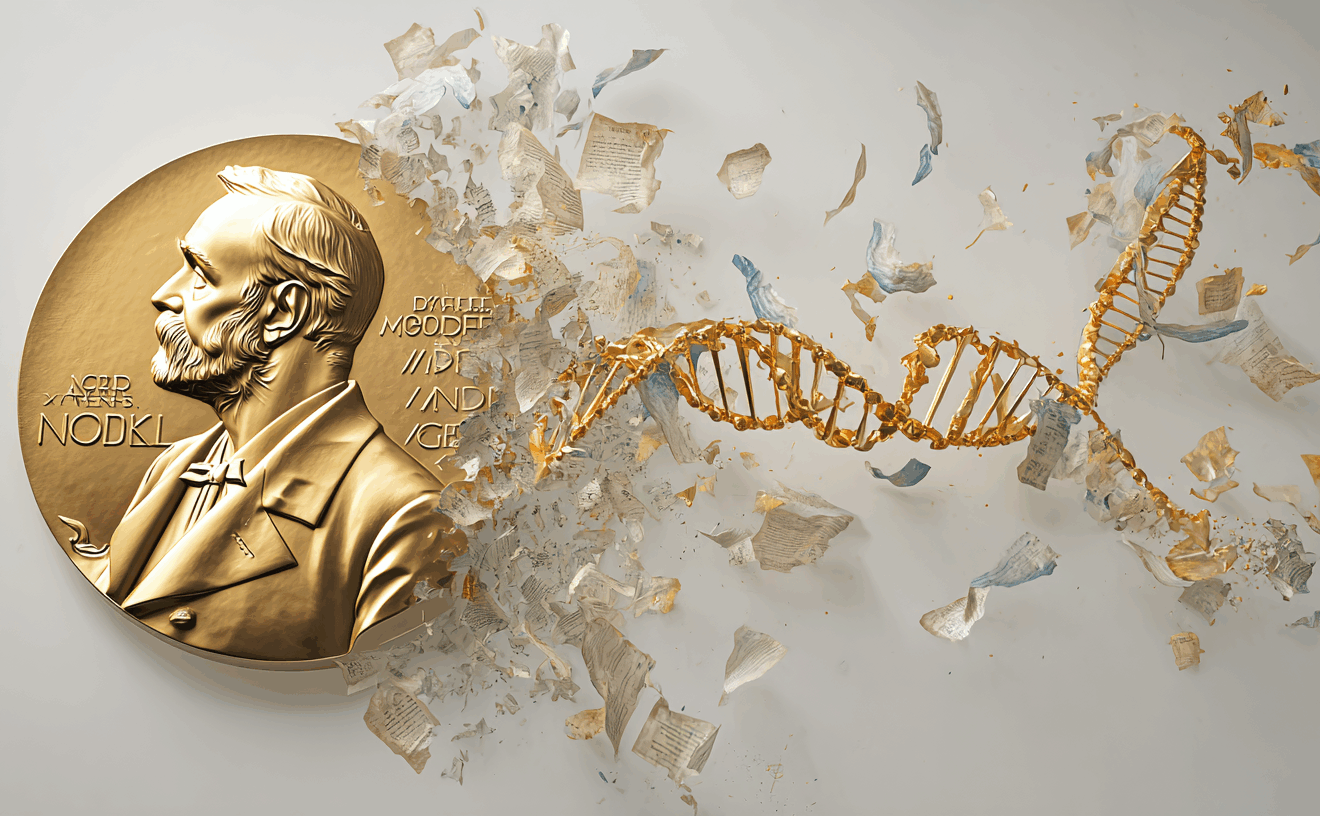Abstract
Anche un’invenzione premiata con il Nobel può perdere la protezione brevettuale. Il caso CRISPR-Cas9, la tecnologia rivoluzionaria sviluppata da Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, mostra quanto possa essere sottile la linea tra scoperta scientifica e invenzione giuridicamente tutelabile. A causa di una divulgazione incompleta e di una pubblicazione anticipata, il gruppo CVC ha perso la priorità su due brevetti fondamentali, optando infine per una “self-revocation strategy” presso l’EPO. In questo articolo analizziamo le ragioni tecniche e giuridiche alla base del caso, spiegando perché la strategia brevettuale non può più essere considerata un passaggio secondario. Dalla sufficienza della divulgazione alle implicazioni industriali, ecco cosa insegna davvero la vicenda CRISPR-Cas9.
Le “forbici” del genoma che hanno vinto il Nobel
Nel 2012, due ricercatrici, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, pubblicarono su Science uno studio destinato a cambiare per sempre la biologia molecolare.
Dimostrarono che un meccanismo naturale di difesa dei batteri poteva essere riprodotto in laboratorio e “programmato” per intervenire sul DNA di una vasta gamma di organismi viventi, con una precisione mai vista prima.
Quel meccanismo si chiama CRISPR-Cas9, ovvero Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – CRISPR-associated protein 9: un sistema molecolare basato sull’enzima Cas9 (Streptococcus pyogenes Cas9, o SpCas9), un’endonucleasi RNA-guidata che consente di identificare e tagliare una sequenza specifica del genoma, proprio come una forbice seleziona e recide un punto esatto in un testo scritto.
Fornendo le “istruzioni” giuste — sotto forma di una breve sequenza guida di RNA — è possibile indirizzare l’enzima Cas9 verso un punto preciso del DNA, determinando il taglio desiderato. In questo modo, una funzione difensiva batterica si trasforma in uno strumento rivoluzionario di editing genetico, capace di correggere mutazioni, migliorare piante, progettare nuove terapie e riscrivere il codice della vita con una semplicità fino ad allora impensabile.
Otto anni dopo quella pubblicazione, nel 2020, Charpentier e Doudna ricevono il Premio Nobel per la Chimica.
La comunità scientifica celebra la loro scoperta come una delle più rivoluzionarie del secolo. Ma mentre la ricerca spinge avanti i confini della biotecnologia, un altro tipo di sfida — meno visibile, ma non meno decisiva — si gioca negli uffici brevetti di tutto il mondo.
Scoperte vs. invenzioni
Nel diritto dei brevetti, “scoprire” e “inventare” non sono la stessa cosa.
- Una scoperta è una realtà già esistente in natura: l’essere umano la osserva, la descrive, ma non la crea.
- Un’invenzione, invece, è l’applicazione concreta e tecnica di quella conoscenza a un risultato utile e riproducibile. Solo questa seconda può accedere alla tutela brevettuale.
Il sistema europeo, regolato dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), stabilisce che ogni invenzione, per essere protetta, debba essere descritta in modo chiaro e completo, tale da consentire a un tecnico del settore di attuarla senza sforzi inventivi aggiuntivi (art. 83 CBE). Lo stesso principio è recepito in Italia dall’articolo 51, comma 3, lettera b) del Codice della Proprietà Industriale (CPI).
Questa condizione è nota come “sufficienza della divulgazione” (sufficiency of disclosure): uno dei pilastri dell’equilibrio tra monopolio brevettuale e condivisione del sapere tecnico. In cambio dell’esclusiva monopolistica, l’inventore è tenuto a divulgare l’invenzione in modo completo e accessibile.
Il sistema CRISPR-Cas9 si è scontrato proprio con questo principio.
Nel maggio 2012, il gruppo CVC (University of California, University of Vienna, Emmanuelle Charpentier) deposita la prima domanda di brevetto europea. Ma nella descrizione manca un elemento essenziale: la sequenza PAM (Protospacer Adjacent Motif), ovvero il frammento di DNA che consente all’enzima Cas9 di riconoscere dove tagliare.
La sequenza PAM sarà aggiunta solo nella domanda successiva, presentata nell’ottobre 2012. Ma nel frattempo, nel giugno dello stesso anno, era già stato pubblicato lo studio scientifico su Science, rendendo pubblici i principi base della tecnologia.
Risultato: l’assenza della sequenza PAM nella prima domanda ha sollevato dubbi sulla sufficienza della divulgazione. E, per estensione, sulla possibilità di rivendicare validamente la priorità. Senza priorità, quella stessa pubblicazione scientifica può essere considerata parte dello “stato dell’arte”, minando i requisiti di novità e altezza inventiva delle rivendicazioni successive.
Non si è trattato di un errore, ma di un difetto giuridico di descrizione.
Nel diritto brevettuale, non sempre vince chi inventa per primo, ma chi documenta meglio e descrive meglio l’invenzione. E in questo caso, la distanza tra l’intuizione scientifica e la sua formalizzazione giuridica è stata sufficiente a mettere a rischio l’intera strategia di protezione giuridica (e il conseguente monopolio legale).
La “self-revocation strategy” nel caso CRISPR
Il cuore della vicenda brevettuale di CRISPR-Cas9 non riguarda tanto la scienza, quanto le conseguenze giuridiche di una descrizione incompleta e di una predivulgazione pericolosa.
Quando i dubbi sollevati davanti all’European Patent Office (EPO) iniziano a consolidarsi, il gruppo CVC si trova davanti a un bivio: difendere i propri brevetti europei in giudizio oppure ritirarli strategicamente prima della decisione formale.
Nel marzo 2025, arriva la scelta: CVC richiede la revoca volontaria dei brevetti EP 2800811 e EP 3401400. Si tratta di due titoli europei centrali nella protezione della tecnologia CRISPR, entrambi basati sulla prima domanda di maggio 2012, ormai considerata insufficiente sotto il profilo della descrizione tecnica.
L’EPO, infatti, aveva espresso pareri preliminari sfavorevoli, segnalando che un tecnico del settore, leggendo quella domanda, non avrebbe avuto gli elementi necessari per attuare l’invenzione. In particolare, l’assenza della sequenza PAM veniva considerata una lacuna tecnica determinante, in grado di compromettere la validità dell’intero impianto brevettuale.
Di fronte al rischio di una revoca formale con decisione pubblica e motivata, i titolari decidono di anticipare l’esito, evitando che una sentenza negativa generi un precedente giurisprudenziale vincolante per le numerose altre domande collegate ancora pendenti.
È una mossa tipica della pratica brevettuale internazionale: meglio ritirarsi da una posizione debole piuttosto che compromettere l’intera linea di difesa.
Poco dopo, anche Sigma-Aldrich compie una scelta analoga: abbandona due suoi brevetti europei (EP 3138911 e EP 3360964), già revocati in primo grado per mancanza di attività inventiva. In quel caso, il ritiro dell’appello serve a contenere l’impatto di una possibile conferma in sede di ricorso.
Queste rinunce — solo in apparenza controintuitive — danno forma a quella che molti commentatori chiamano “strategia di auto-revoca” (self-revocation strategy): una linea difensiva che, invece di difendere titoli incerti, li sacrifica per proteggere portafogli più ampi e rafforzare future rivendicazioni.
Ma anche la prudenza ha un prezzo.
Ogni brevetto ritirato apre un vuoto, e ogni vuoto genera incertezza operativa. In un settore competitivo come quello delle biotecnologie avanzate, le imprese che sviluppano soluzioni basate su CRISPR-Cas9 si trovano a navigare un panorama brevettuale frammentato, fatto di licenze multiple, know-how parzialmente già reso pubblico e implicazioni legali difficili da prevedere.
Perché la tutela brevettuale non è un aspetto secondario
Il caso CRISPR non è solo una questione di brevetti: è una lezione su quanto sia importante la strategia legale nella gestione del sapere scientifico.
Nei laboratori più avanzati del mondo, la linea che separa una scoperta da un’invenzione non è solo tecnica, ma strategica.
E proprio per questo i dipartimenti di ricerca e sviluppo operano nel riserbo più assoluto: perché decidere quando, come e cosa brevettare non è un passaggio formale, ma una scelta industriale con ripercussioni economiche concrete, spesso irreversibili.
Nel diritto brevettuale, anticipare una pubblicazione di qualche settimana, o descrivere in modo impreciso un passaggio chiave del brevetto, può voler dire perdere la protezione di un’intera famiglia di titoli. Con il rischio di vedere tecnologie proprietarie rese liberamente utilizzabili da terzi.
Il gruppo CVC, con il suo ritiro volontario dei brevetti europei EP 2800811 e EP 3401400, ne ha offerto un esempio evidente. Una mossa difensiva, certo. Ma anche un segnale sintomatico.
Oggi, chi opera nell’editing genetico, nell’intelligenza artificiale o nelle scienze dei materiali sa che il valore di una scoperta dipende anche dalle scelte legate all’architettura brevettuale. E questa architettura deve essere pianificata con cura.
Una strategia efficace implica:
- Controllare la tempistica della divulgazione scientifica, evitando che una pubblicazione anticipi il brevetto, distruggendo la novità dello stesso;
- Costruire descrizioni tecniche razionali, in grado di soddisfare i requisiti normativi nei diversi ordinamenti e di definire gli argini della protezione monopolistica;
- Coordinare la gestione delle priorità internazionali, evitando conflitti e decadenze.
La protezione dell’innovazione è parte integrante dell’innovazione stessa. La tutela legale non è una fase successiva: è una componente del progetto, al pari della validazione sperimentale o del modello di business.
CRISPR-Cas9 ha riscritto il codice della vita. Ma ci ricorda anche che il diritto è centrale nella scienza. Governarlo bene può fare la differenza tra il recupero degli investimenti in innovazione e la disseminazione dei risultati della ricerca, con una perdita irreversibile.
© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 30 Ottobre 2025
È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.