Abstract
Il caso Nosferatu (1922) è uno dei più celebri esempi di plagio nella storia del cinema e ha sollevato questioni ancestrali sulla proprietà intellettuale. Ma oltre la controversia legale, cosa distingue Nosferatu dal Dracula di Bram Stoker? I vampiri ci affascinano da secoli, incarnando il desiderio di immortalità e la paura della morte. Se Dracula ha conquistato il pubblico con il suo carisma seduttivo, Nosferatu rappresenta un terrore primitivo e inarrestabile. Dal Dracula di Coppola al Nosferatu di Robert Eggers (2025), il mito si è trasformato, adattandosi ai cambiamenti culturali. E se oggi il vampiro fossimo noi? In un mondo segnato da conflitti e consumismo sfrenato, il vampiro diventa metafora della nostra stessa natura predatoria. La domanda finale resta aperta: abbiamo ancora il potere di fermarci prima che sia troppo tardi?
Nel 2025, Nosferatu è risorto dalle tenebre
Il film Nosferatu – quello del 1922 – oggi potrebbe sembrare distante dai canoni della godibilità contemporanea, ma resta una pietra miliare della storia del cinema. Se siete curiosi di vederlo, sappiate che è disponibile gratuitamente su YouTube (Nosferatu il vampiro 1922 F.W. Murnau).

Max Schreck in Nosferatu il vampiro (1922)
Ma perché è così importante? Ad esempio, il mito secondo cui il vampiro si riduca in cenere alla luce del sole – oggi un elemento fondamentale della cultura pop – è nato proprio con Murnau. Sorprendentemente, questa caratteristica non era presente nel Dracula di Bram Stoker.
Eppure, sebbene le trame dei due racconti siano simili, l’essenza dei loro vampiri è profondamente diversa. Dracula e Nosferatu si somigliano, ma quest’ultimo è privo di umanità, una presenza spettrale che ci turba in un modo del tutto differente. Ma perché?
Per capirlo, dobbiamo addentrarci nel cuore del mito dei vampiri. Perché, diciamolo, non hanno mai smesso di affascinarci.
I vampiri, dal primo all’ultimo
Nel 2024, il vampiro Nosferatu è tornato sotto i riflettori grazie al recente remake di Robert Eggers, uscito nelle sale italiane a gennaio. Con Bill Skarsgård nei panni del Conte Orlok e Lily-Rose Depp – figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis – nel ruolo di Ellen Hutter, il nuovo film ha riportato in vita un “tipo” di vampiro che rischiavamo di dimenticare per sempre.
Ma procediamo per gradi.
Stando alla documentazione storica, il primo vero vampiro, in senso stretto, pare sia stato Jure Grando Alilović, un contadino istriano di Corridico. Secondo la leggenda, pur essendo morto nel 1656, il suo corpo sarebbe stato riesumato e decapitato nel 1672, perché – si dice – per anni si sarebbe destato ogni notte per terrorizzare il villaggio.
Ma le storie di creature avide di sangue risalgono addirittura all’antichità. Intorno al 3000 a.C., in Mesopotamia, le Lilith erano demoni notturni che tormentavano gli uomini e uccidevano i bambini. Nell’antica Grecia, invece, erano le Lamia a sedurre le vittime per poi divorarle.
Questi miti erano alimentati dalla paura dell’ignoto e servivano probabilmente a giustificare malattie inspiegabili e morti improvvise. Ogni volta che una comunità veniva colpita da un’epidemia – come peste o tubercolosi – il mito del vampiro tornava in auge. Il vampiro era una spiegazione terribile, ma efficace, e diventava il capro espiatorio perfetto.
Non a caso, fu tra il 1600 e il 1700, durante le cosiddette “epidemie di vampiri”, che il folklore europeo prese definitivamente radici. Cadaveri con tracce di sangue intorno alla bocca (un normale effetto della decomposizione) e la presunta crescita di unghie e capelli (dovuta semplicemente alla disidratazione della pelle) erano segnali inequivocabili: il defunto era un non-morto. Se poi il freddo rallentava la decomposizione, il sospetto diventava certezza.
A quel punto, la soluzione era una sola: un paletto di frassino o una decapitazione per mettere fine all’epidemia di tubercolosi. La paura era tale che persino Maria Teresa d’Austria si sentì in dovere di intervenire. L’imperatrice incaricò il suo medico di corte, Gerard van Swieten, di indagare. Il verdetto fu netto: le credenze popolari erano prive di fondamento. Ne seguì un decreto che vietava tutti i rituali legati al vampirismo (si v. Processo ai non-morti: quando i vampiri terrorizzavano l’Est Europa).
Ma, ironia della sorte, invece di spegnere il mito, lo alimentò. Perché, si sa, non c’è niente di più affascinante del proibito.
E così il vampiro divenne un blockbuster, prima nella letteratura, poi nel cinema.
Nosferatu: il plagio più celebre della storia del cinema?
La vera consacrazione del vampiro avvenne nel XIX secolo, grazie alla letteratura gotica. Opere come Il Vampiro di John Polidori (1819) e il romanzo epistolare Dracula di Bram Stoker (1897) trasformarono il vampiro in un’icona culturale: un essere tormentato, bramoso di sangue e immortale.
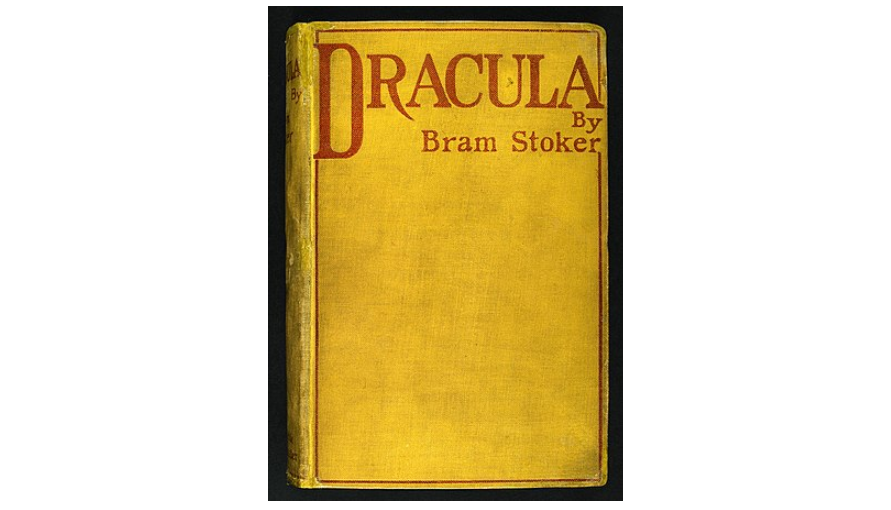
Dracula, di Bram Stoker – Copertina in tela della prima edizione, 1897
Un articolo de Il Post del 31 dicembre 2024, intitolato “Il primo ‘Nosferatu’ non avremmo nemmeno dovuto vederlo”, approfondisce con grande accuratezza le vicende legali legate all’uscita del celebre film di Murnau. Vediamo qui solo le storie a confronto.
C’era una volta… Dracula
Un giovane avvocato, di nome Jonathan Harker, si reca in Transilvania per assistere un misterioso Conte nell’acquisto di una proprietà in Inghilterra, la Carfax Abbey. Jonathan resta intrappolato nel castello del Conte, mentre quest’ultimo si dirige in Inghilterra con l’intento di insidiare la fidanzata di Jonathan, Mina Murray. Sia Mina che la sua amica Lucy Westenra cadono vittime di Dracula e si trasformano in vampiri, ma il celebre professor Van Helsing, esperto di creature oscure, insieme a un gruppo di temerari, combatte per sconfiggere Dracula. Dopo una serie di lotte, inseguimenti e sacrifici, il gruppo riesce ad avere la meglio, ponendo fine al regno del leggendario Conte. Fine della storia. O forse no.
C’era una volta… Nosferatu
Un giovane agente immobiliare di nome Hutter si reca nei Carpazi per assistere un misterioso Conte nell’acquisto di una proprietà in Germania, nella città di Wisborg. Ma una volta giunto al castello, Hutter scopre di essere prigioniero del Conte Orlok.
Nel frattempo, Orlok viaggia verso Wisborg, portando con sé topi e pestilenza. La sua presenza semina morte e terrore, mentre sua moglie Ellen sembra l’unica capace di fermarlo. Seguendo un antico libro sui vampiri, Ellen scopre che se una donna dal cuore puro trattiene il Conte fino all’alba, lui perirà. Così, Ellen sacrifica se stessa: Orlok si attarda troppo e, con il primo raggio di sole, si dissolve nel nulla.
E così finisce la storia del Conte Orlok. Che somiglia terribilmente a quella del Conte Dracula. Forse un po’ troppo.
In realtà, la casa di produzione Prana Film, fondata dall’occultista Albin Grau, aveva tentato di acquistare i diritti del romanzo di Stoker, senza successo. Così, il regista F.W. Murnau decise di girare comunque il film, modificando nomi e dettagli per cercare di evitare problemi legali.
Ma la vedova di Bram Stoker, Florence Balcombe, non la prese affatto bene. Intentò una causa per violazione del diritto d’autore e vinse. Il tribunale ordinò la distruzione di tutte le copie del film, ma alcune copie clandestine fortunatamente riuscirono a sopravvivere.
E così Nosferatu si salvò, diventando uno dei capolavori indiscussi del cinema espressionista tedesco. The end.
Dunque, c’è plagio e plagio. E, a ben vedere, non tutti i plagi vengono per nuocere…
Dracula vs Nosferatu: due volti del vampiro
Nosferatu è un caso celebre di plagio, ma più che sulle questioni legali, qui voglio soffermarmi sulle sue differenze rispetto a Dracula. Perché non si tratta solo di una questione di nomi cambiati per evitare una causa: le due opere sono radicalmente diverse, tanto dal punto di vista estetico quanto concettuale.
Dracula non è mai morto davvero…
Se Nosferatu ha rischiato di scomparire, Dracula invece non è mai morto davvero. È sopravvissuto, trasformandosi e adattandosi a ogni epoca. Dracula esplora temi di seduzione, esotismo e il conflitto tra tradizione e modernità.
Il cinema ha consacrato il suo mito, senza stancarsi mai di portarlo sullo schermo:
- Dracula di Tod Browning (1931), con Bela Lugosi, ha dato al vampiro il suo volto più iconico nell’era classica di Hollywood.
- Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola (1992) ha reso il vampiro un’icona estetica degli anni ’90, tra lusso barocco e romanticismo gotico. Gary Oldman, con il suo Dracula malinconico e passionale, ha incarnato un vampiro più seduttivo che mostruoso, perfettamente in linea con un’epoca ossessionata dall’estetica e dalla moda.
- Negli stessi anni, Intervista col vampiro di Neil Jordan (1994), con Tom Cruise e Brad Pitt, ha portato il vampiro a un livello successivo, trasformandolo in una figura decadente, filosofica… persino più affascinante della sua controparte horror.
- Poi è arrivato Twilight (2008), che ha fatto brillare il vampiro sotto il sole, trasformandolo in un oggetto di desiderio adolescenziale più che in una creatura della notte.
Ma cosa rende queste creature così magnetiche? La risposta sta nella loro capacità di incarnare le contraddizioni più profonde dell’essere umano.
Il vampiro è l’eterno conflitto tra vita e morte. L’immortalità è uno dei desideri più antichi dell’uomo, ma il vampiro ne mostra il prezzo più alto: un’esistenza solitaria, maledetta, parassitaria. Questo dualismo tra il fascino di vivere per sempre e il tormento che ne deriva ha reso il vampiro una figura tragica e universale.
Il vampiro è anche ambiguità morale e attrazione proibita. È il “diverso” per eccellenza, fuori dalla società e dalle sue regole, ma al tempo stesso irresistibile, capace di soggiogare con il suo potere e la sua sensualità. È il predatore e la preda, il carnefice e la vittima, la tentazione e la dannazione.
Nosferatu: la paura collettiva della morte
Se Dracula è desiderio e seduzione, Nosferatu è paura e repulsione. Il suo universo non è fatto di carisma e ambiguità, ma di morte inevitabile, pestilenza e decadenza. Avevamo deciso di distruggerlo per plagio? O inconsciamente volevamo dimenticarlo?
Il film di Murnau (1922), con il suo stile, costruisce un mondo onirico e angosciante attraverso il gioco di ombre e luci contrastanti. Il Conte Orlok non è un aristocratico elegante, ma una creatura primitiva e spaventosa, più simile a un topo infestante che a un seduttore. Nosferatu non seduce, Nosferatu contagia.
E nel suo mondo non c’è spazio per il compromesso. Nosferatu distrugge tutto, finisce per distruggere anche se stesso. L’umanità resta intatta solo attraverso il sacrificio di Ellen, che offre la propria vita per fermarlo. Ma non c’è redenzione per il vampiro: lui si dissolve.
Insomma, a differenza di Dracula, Nosferatu non si è mai davvero evoluto. Non ha sedotto, non ha brillato, non ha cavalcato le mode. È rimasto un incubo primitivo, legato alla morte e alla pestilenza.
E se fossimo noi il vampiro?
Nel Nosferatu di Robert Eggers (2024), il vampiro si abbandona definitivamente al lato oscuro. Il Conte Orlok, interpretato da Bill Skarsgård, è pura distruzione: un predatore insaziabile, che consuma tutto ciò che incontra, compreso sé stesso. Ma accanto a questa forza devastante, emerge un altro volto dell’umanità: Ellen Hutter, interpretata da Lily-Rose Depp, che sceglie il sacrificio per fermarlo.
La sua scelta non è solo eroica, ma simbolica. Ellen rappresenta quella parte di umanità che riconosce il pericolo e sceglie di opporsi al ciclo distruttivo. Mentre Orlok incarna l’avidità e il desiderio di possesso che divorano il mondo, Ellen è la consapevolezza che, nonostante tutto, esiste ancora una possibilità di redenzione.
Ma guardando oltre la leggenda, chi è davvero il vampiro oggi? In un’epoca di crescenti tensioni globali, conflitti, sfruttamento delle risorse e distruzione ambientale, la figura del vampiro assume una nuova rilevanza. La sua fame insaziabile è la nostra, il suo bisogno di consumare senza limiti rispecchia una civiltà che rischia di divorare sé stessa.
L’uomo è l’unico vero vampiro. La sua figura ci costringe a guardare le nostre ombre, a confrontarci con la nostra natura predatoria. Ma il sacrificio di Ellen ci ricorda che, anche di fronte all’oscurità più profonda, restando umani, abbiamo ancora il potere di scegliere.
Forse, alla fine, il vampiro siamo noi. E la vera domanda non è se esista un mostro là fuori, ma se abbiamo ancora la forza di riconoscerlo dentro di noi… per fermarlo prima che sia troppo tardi.
© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 7 Febbraio 2025
Ultimo aggiornamento: 13 Giugno 2025
È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Arlo Canella
Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.
