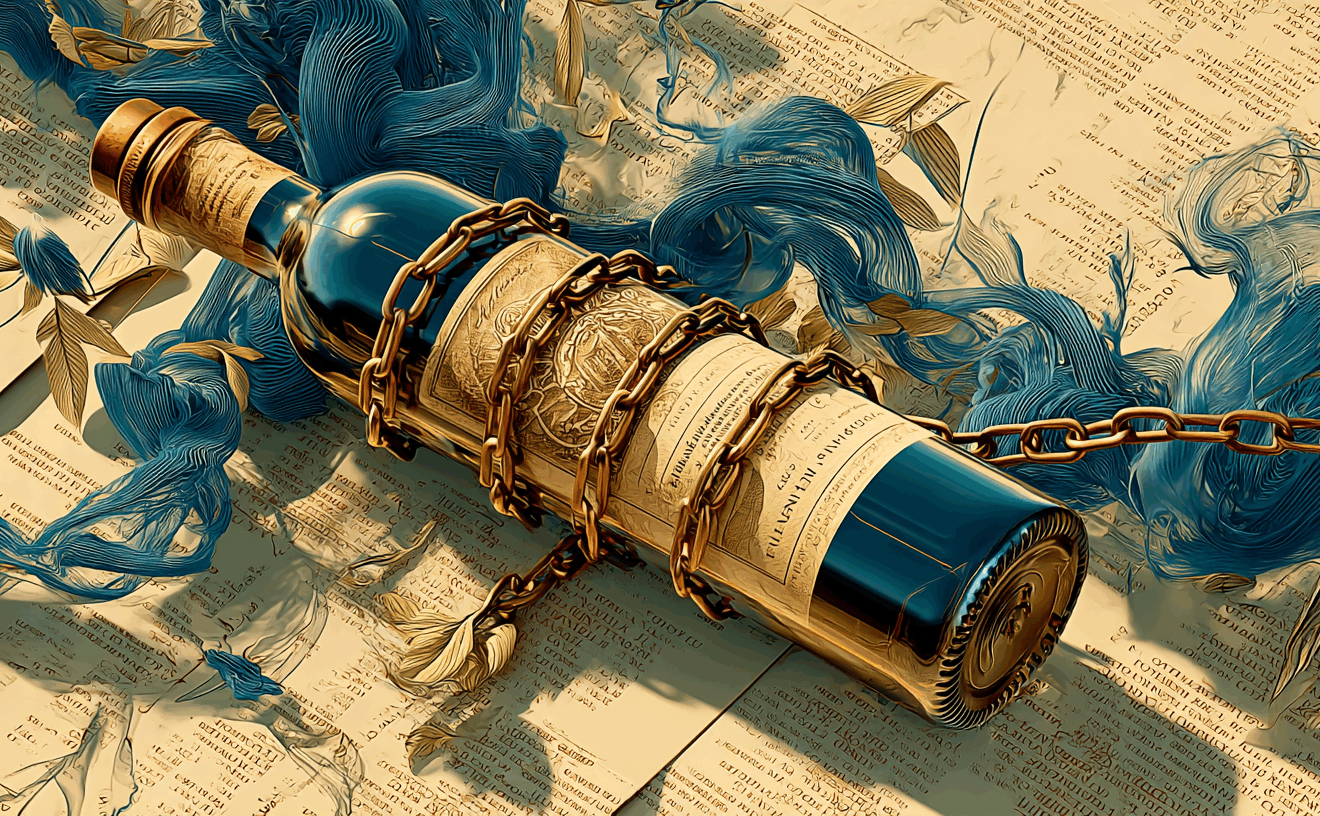Abstract
L’olio extravergine di oliva è uno dei simboli del Made in Italy, ma anche uno dei prodotti più vulnerabili a frodi e sofisticazioni. Il Report 2024 dell’ACN (Alert & Cooperation network), pubblicato dalla Commissione europea il 16 maggio 2025, evidenzia un dato allarmante: l’olio d’oliva è tra i prodotti più frequentemente oggetto di misclassificazione, adulterazione e false evocazioni, con 130 notifiche solo nel 2024, il 15% delle quali qualificate come frodi transfrontaliere.
In questo articolo esploriamo le pratiche illecite più diffuse, il sistema di controlli ufficiali e le sanzioni previste dalla normativa italiana ed europea. Perché difendere l’olio significa proteggere la qualità dell’azienda, la legalità del prodotto e la fiducia dei consumatori.
Frodi nell’olio di oliva: quando l’inganno è questione di sfumature
Non serve aggiungere sostanze tossiche per trasformare un olio d’oliva in una frode. A volte, basta togliere la verità. L’aggiunta di un colore, l’omissione di una parola, la scelta strategica di una dicitura evocativa possono bastare a spostare un prodotto dal lecito all’illecito. E quando si parla di olio extravergine d’oliva – uno dei simboli più celebrati del Made in Italy – queste manipolazioni non sono eccezioni: sono meccanismi rodati, sistemici, in alcuni casi persino normalizzati.
Lo conferma l’Annual Report 2024 della Alert and Cooperation Network (ACN) della Commissione europea, pubblicato il 16 maggio 2025: il comparto dell’olio d’oliva è oggi uno dei più colpiti da frodi alimentari a livello europeo.
Ma che cosa si intende per frode in questo contesto? Le casistiche sono diverse e talvolta sofisticate. Secondo i dati ufficiali ACN, la maggioranza dei casi – il 62 % – riguarda “misrepresentation”, ovvero presentazione ingannevole della qualità: olio lampante spacciato per extravergine, miscele dichiarate come monocultivar, oli ossidati o deodorati presentati come freschi e artigianali. Il trucco più usato? Rimuovere i composti responsabili dell’odore sgradevole mediante processi chimici non dichiarati – e legalmente vietati – per poi rivendere l’olio come extravergine.
Seguono, con il 15%, i casi di etichettatura ingannevole: qui il confine tra frode e scorrettezza commerciale si fa più sottile. L’uso di stemmi tricolore, termini come “italiano”, immagini di colline toscane o frantoi pugliesi su bottiglie contenenti oli esteri (magari solo confezionati in Italia) costituisce una delle più comuni forme di evocazione ingannevole, pratica vietata dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, riconducibile anche alle norme nazionali in materia di pubblicità ingannevole e tutela del consumatore (D.Lgs. 145/2007 e D.Lgs. 206/2005)
Più tecnicamente fraudolente sono le diluizioni: il 10% delle segnalazioni riguarda la sostituzione parziale con oli più economici (di sansa, di semi, raffinati). Queste frodi, difficili da percepire a occhio nudo, sono rilevabili solo tramite analisi avanzate (profilo degli acidi grassi, contenuto di steroli, traccianti isotopici), che confermano l’affidabilità dei metodi sensoriali e spettroscopici come strumenti di contrasto alle sofisticazioni. Proprio per questo motivo, l’olio d’oliva è considerato una delle matrici più vulnerabili alla sofisticazione a basso rischio, come evidenziato nella review del 2024 Recent methods in detection of olive oil adulteration: State-of-the-Art.
Tra le forme più insidiose vi è anche quella dell’evocazione di qualità non dimostrate: l’indicazione “estratto a freddo” è lecita solo se l’intero processo è avvenuto sotto i 27 °C, come stabilito dall’articolo 10 del Regolamento (UE) 2022/2104. Troppe aziende la utilizzano senza verificarne la conformità. Lo stesso vale per diciture come “prima spremitura” o “olio novello”, spesso associate a pratiche standard, senza reale fondamento tecnico. In particolare, il termine “olio novello” non è definito da alcuna norma europea: si tratta di una menzione commerciale libera, che resta tuttavia soggetta ai principi di veridicità e non ingannevolezza stabiliti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) 1169/2011.
Infine, vi è un tipo di frode che non riguarda solo la bottiglia, ma l’intero sistema dichiarativo e fiscale: il fenomeno dell’“olio di carta”, descritto nel Rapporto ICQRF 2024, consiste nella creazione fittizia di volumi di produzione, gonfiando le rese o falsificando la documentazione. Lo scopo? Introdurre nel mercato oli stranieri come se fossero italiani. Si tratta non solo di un danno per il consumatore, ma di una lesione sistemica alla filiera e alla reputazione internazionale dell’olio italiano.
In tutte queste forme, la frode non è solo un reato: è una violazione della fiducia. E in un mercato in cui l’identità territoriale e la qualità sensoriale sono parte del valore, la verità è ciò che rende un olio davvero extravergine.
I controlli ufficiali: chi vigila sull’olio che portiamo in tavola
Se la frode alimentare è l’ombra, il controllo ufficiale è la luce che la rivela. E nel caso dell’olio d’oliva, l’Unione Europea ha costruito una rete di sorveglianza tra le più sofisticate. La vigilanza inizia dalla produzione e arriva fino allo scaffale, grazie a sistemi integrati di tracciabilità, analisi chimiche e controlli sensoriali.
In Italia, l’organo centrale è l’ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, che nel 2023 ha condotto oltre 11.000 controlli nel comparto olivicolo, con 777 irregolarità riscontrate, 387 sanzioni amministrative e oltre 1.100 tonnellate sequestrate.
Le verifiche non si fermano alla filiera produttiva. Grazie al Registro Telematico dell’Olio, obbligatorio per tutti gli operatori del settore, è possibile monitorare ogni passaggio: produzione, stoccaggio, imbottigliamento, movimentazione. Ogni litro deve essere documentato digitalmente, riducendo le possibilità di introduzione di “olio di carta” o di partite non conformi. Il D.M. 23 dicembre 2013 disciplina l’uso del registro, integrando le norme della Legge n. 9/2013 (la cosiddetta “legge salva olio”).
In campo europeo, il quadro normativo è definito dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla comune organizzazione dei mercati agricoli, integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/2104, che fissa standard di commercializzazione per l’olio d’oliva. Ed è proprio nell’ambito di questi regolamenti che si inseriscono i controlli di categoria e le verifiche di etichettatura, i cui dati sono raccolti e pubblicati ogni anno dalla Commissione europea – DG AGRI.
Nel periodo 2020–2023, le non conformità si sono mantenute stabili: circa il 17% delle etichette e il 34% delle verifiche di categoria risultano non conformi (ACN Report 2024, pag. 29). Si tratta di cifre importanti, che mostrano come la battaglia per la trasparenza sia tutt’altro che vinta.
Quando una non conformità assume rilevanza transfrontaliera o riguarda una frode, scatta la segnalazione alla Rete ACN (Alert and Cooperation Network), lo snodo centrale della cooperazione tra Stati membri. È anche grazie a questo sistema che è possibile bloccare, ritirare o sequestrare prodotti adulterati prima che raggiungano il consumatore finale.
Ma il controllo non è solo repressione. È anche tutela della reputazione di un comparto strategico per il Paese. Come dimostra il successo del contrassegno di sicurezza adottato da alcune IGP – come l’Olio di Roma IGP – dotato di QR code univoco e sistema anticontraffazione: un’iniziativa che rappresenta la nuova frontiera della tracciabilità digitale e della certificazione dell’origine.
Le sanzioni previste: quando l’olio inganna, la legge risponde
Dietro l’illusione di un’etichetta evocativa può nascondersi una responsabilità giuridica tutt’altro che leggera. Se il consumatore è tratto in inganno, la legge parla chiaro: l’etichettatura ingannevole non è solo una scorrettezza commerciale, ma può costituire un reato. Il mercato dell’olio d’oliva – tanto redditizio quanto vulnerabile – è sorvegliato da un sistema normativo che combina sanzioni amministrative, penali e misure interdittive.
Il cuore del sistema repressivo è rappresentato dalla già citata Legge n. 9/2013, che ha introdotto un inasprimento delle pene per la contraffazione e un rafforzamento degli strumenti di tracciabilità. A questa si affianca il D.Lgs. 231/2017, che disciplina le sanzioni per la violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore prevedendo multe fino a 24.000 euro, il sequestro dei prodotti e, nei casi più gravi, la denuncia penale per frode in commercio.
Secondo questo quadro, dichiarare “extravergine” un olio che non ha superato i panel test, omettere l’origine geografica o impiegare diciture non autorizzate può comportare multe fino a 24.000 euro, il sequestro del prodotto e, nei casi più gravi, la denuncia penale per frode in commercio.
Non si tratta di ipotesi remote. Solo nel 2023, il Ministero dell’Agricoltura ha trasmesso 42 notizie di reato all’autorità giudiziaria per violazioni nel comparto olivicolo. E alcuni casi hanno fatto scuola: è il caso dell’olio Carapelli, al centro di una vicenda che ha visto il produttore sanzionato con oltre 230.000 euro per avere presentato come “extravergine” un prodotto che non ne rispettava i requisiti chimici e organolettici (ne abbiamo parlato nell’articolo Dicitura obbligatoria o pratica commerciale? L’etichettatura tra trasparenza e responsabilità legale).
A livello europeo, il Regolamento delegato (UE) 2022/2104 ha rafforzato le regole di classificazione e commercializzazione dell’olio, rendendo obbligatorie analisi comparative tra dichiarato in etichetta e caratteristiche reali del prodotto. Il rispetto di tali standard è ormai parte integrante delle ispezioni trasfrontaliere e delle notifiche diramate tramite la Rete ACN, come dimostra il dato preoccupante del 2024: 130 segnalazioni relative all’olio d’oliva, il 15% delle quali riconosciute come vere e proprie frodi di natura transfrontaliera (ACN Annual Report 2024, pag. 29).
Questi numeri non parlano solo di multe. Parlano di mercato alterato, di leale concorrenza compromessa, di reputazioni danneggiate. Parlano di aziende oneste che rischiano di pagare il prezzo delle scorciatoie altrui. È per questo che la compliance normativa non è più un’opzione, ma una strategia di tutela e posizionamento competitivo.
Come tutelarsi: doveri per i produttori e strumenti per i consumatori
La legalità, nel mondo dell’olio extravergine di oliva, non è solo un presidio normativo: è una strategia di posizionamento. In un mercato esposto a sofisticazioni, evocazioni scorrette e concorrenza sleale, la trasparenza è diventata un valore competitivo. Ma come si traduce, in concreto, in comportamenti virtuosi e verificabili?
Per i produttori, tutto parte da una parola: documentazione. Ogni passaggio, dalla molitura alla confezione, deve essere tracciato, verificabile e coerente con quanto indicato in etichetta. Il registro telematico dell’olio, introdotto dalla Legge n. 9/2013 e oggi gestito digitalmente dall’ICQRF, è uno strumento essenziale: permette di monitorare ogni litro, ogni lotto, ogni movimento, riducendo al minimo i margini di opacità.
Ma la trasparenza non si limita ai documenti: l’etichettatura deve parlare chiaro, con rigore scientifico e rispetto normativo. Origine, categoria, metodi di estrazione, annata, certificazioni di qualità (IGP, DOP) devono corrispondere al vero, con evidenze analitiche e, quando necessario, panel test a supporto. È qui che l’assistenza legale specializzata diventa un’alleata strategica: non solo per evitare sanzioni, ma per costruire un’identità commerciale robusta, capace di resistere alle sfide dei mercati internazionali.
Nel frattempo, anche i consumatori non sono più spettatori passivi. Sempre più spesso cercano strumenti di verifica, come la Carta d’identità dell’olio extravergine e contrassegni di sicurezza anticontraffazione, ispirati alle tecnologie delle banconote: microcaratteri, ologrammi, codici QR e blockchain garantiscono l’originalità del prodotto e ne proteggono il valore.
Tecnologie emergenti come sistemi basati su blockchain integrata con l’Internet of Things (IoT) consentono inoltre una tracciabilità in tempo reale lungo tutta la filiera, creando registri immutabili che rafforzano la trasparenza e contrastano le frodi (Blockchain-IoT system, 2025). Consultarli prima di acquistare è un gesto semplice, ma rivoluzionario: trasforma l’etichetta in un patto di fiducia.
Il risultato? Un nuovo equilibrio tra legalità e marketing, tra rigore analitico e narrazione del territorio. Perché oggi la qualità non si dichiara: si dimostra, si certifica, si racconta. E solo chi integra norme, scienza e comunicazione è davvero pronto ad affrontare il futuro dell’olio d’oliva.
Bibliografia
Hashempour-Baltork F. Recent methods in detection of olive oil adulteration: State-of-the-Art. 2024. ScienceDirect.
Vitaskos, V., Demestichas, K., Karetsos, S., & Costopoulou, C. (2024). Blockchain and Internet of Things Technologies for Food Traceability in Olive Oil Supply Chains. Sensors (Basel, Switzerland), 24(24), 8189. DOI:10.3390/s24248189
Bobbiesi C. L’etichetta dell’olio di oliva: verità, frodi e differenze che fanno la qualità. Canella Camaiora Studio Legale. 2025
Bobbiesi C. Come leggere l’etichetta dell’olio extravergine: origine, qualità e legalità. Canella Camaiora Studio Legale. 2025
European Commission. Alert & Cooperation Network (ACN) Annual Report 2024. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2025.
Bobbiesi C. Dicitura obbligatoria o pratica commerciale? L’etichettatura tra trasparenza e responsabilità legale. Canella Camaiora Studio Legale. 2025
© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 27 Agosto 2025
È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.