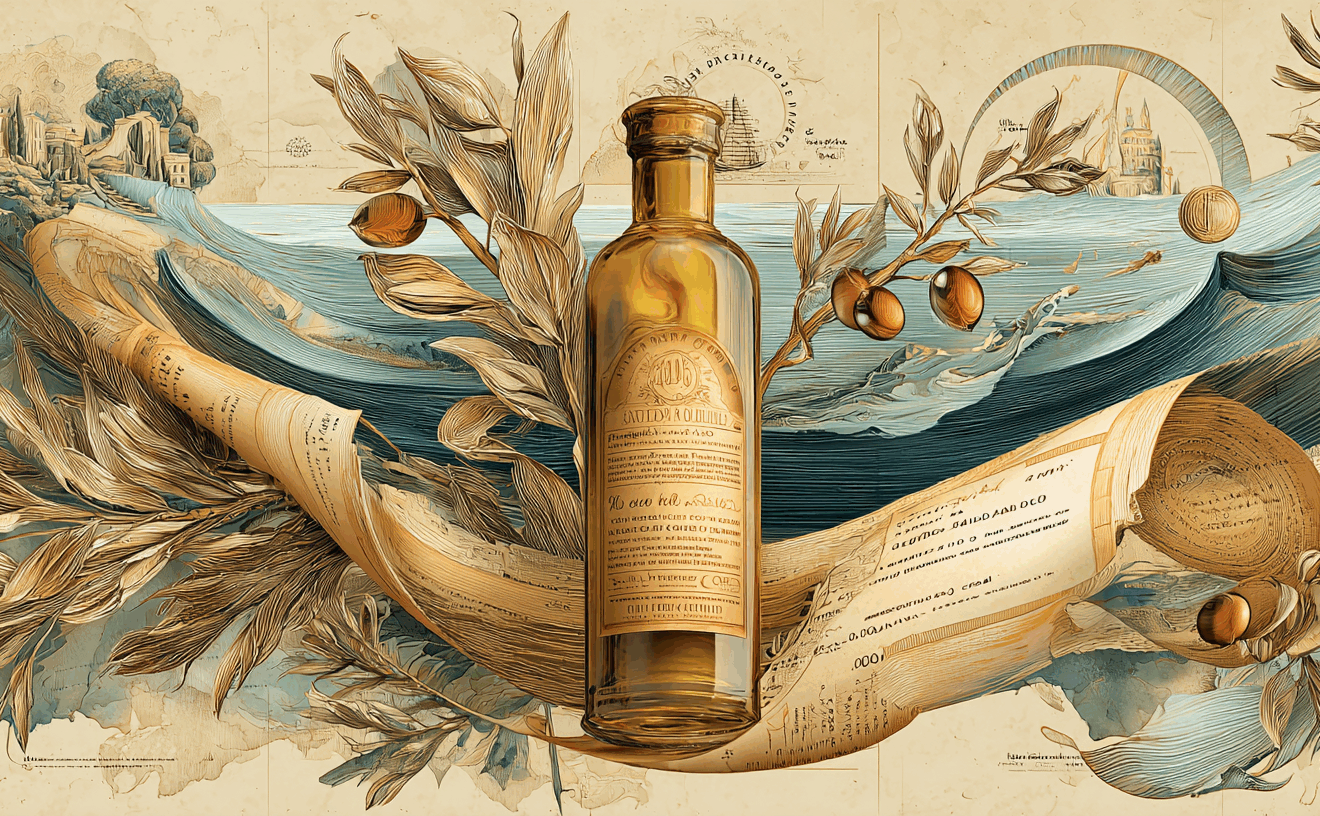Abstract
“Extravergine”: basta questa parola per evocare colline assolate, ulivi secolari e il profumo pungente di un prodotto che è simbolo dell’identità italiana. Ma quanta verità si cela davvero dietro a un’etichetta così? E quanto, invece, è frutto di omissioni, fraintendimenti o, nei casi peggiori, vere e proprie frodi? L’etichetta dell’olio d’oliva non è mai solo un foglio adesivo: è la dichiarazione di identità di un alimento profondamente culturale, tutelato da una normativa complessa. Conoscere le regole che ne governano la denominazione, la composizione, l’origine e la qualità significa saper distinguere un vero extravergine da una buona imitazione, e proteggere il valore di un’intera filiera.
Un prodotto simbolo e una disciplina speciale
C’è qualcosa di profondamente mediterraneo nel gesto di versare l’olio. Un filo d’oro sul pane, un soffritto che apre il pasto, un sapore che racconta storie di 6.000 anni fa. Ma se l’olio extravergine è cultura, sapore e salute, è anche, oggi più che mai, un bene regolato, protetto e osservato con attenzione crescente da mercati, autorità e consumatori.
Secondo i dati COI e ISMEA 2024/25, l’Italia si posiziona tra i primissimi al mondo per consumo di olio di oliva e detiene il primato globale per numero di denominazioni DOP e IGP. Eppure, proprio in questo mercato maturo e identitario, si sono moltiplicate le criticità: dalla concorrenza spagnola sempre più aggressiva all’aumento delle importazioni extracomunitarie, fino al crollo del consumo interno registrato negli ultimi anni. In questo scenario, la trasparenza dell’etichetta diventa fondamentale: non solo per tutelare il consumatore, ma anche per garantire equità e competitività tra produttori.
Per questo l’olio d’oliva, e in particolare l’extravergine, è oggi al centro di una disciplina normativa articolata. Alle regole generali sull’informazione alimentare dettate dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, si affiancano norme verticali che definiscono nel dettaglio la classificazione merceologica, i criteri di qualità e i requisiti etichettabili. Spiccano, in particolare, i Regolamenti (UE) 2022/2104 e 2022/2105, che fissano parametri chimici e sensoriali, obblighi di denominazione e standard per l’origine. In ambito nazionale, la legge n. 9/2013, nota come “salva olio”, ha rafforzato la tracciabilità e le sanzioni per l’etichettatura ingannevole, anticipando molte delle misure oggi riprese a livello europeo.
In questo contesto, l’etichetta non è un dettaglio grafico o una scelta di marketing. È uno spazio giuridico: un luogo in cui convergono obblighi normativi, responsabilità produttive e diritti del consumatore. Capirla, leggerla correttamente e redigerla in conformità alle regole significa proteggere un patrimonio, evitare sanzioni e restituire autenticità a un prodotto simbolo del made in Italy.
Vergine, extravergine, raffinato: non solo questione di gusto
Non tutti gli oli d’oliva sono uguali. Dietro quella bottiglia che troviamo sugli scaffali si cela una classificazione complessa, che il legislatore europeo ha definito con precisione per garantire chiarezza, sicurezza e correttezza commerciale (Reg. (UE) n. 1308/2013, Allegato VII, Parte VIII).
L’olio extravergine di oliva – il più pregiato e richiesto – è ottenuto esclusivamente mediante procedimenti meccanici, senza alcun trattamento chimico, e deve rispettare parametri rigorosi: acidità libera non superiore allo 0,8% e assenza di difetti organolettici rilevabili. L’olio vergine, pur sempre naturale, ammette invece una maggiore acidità (fino al 2%) e leggere imperfezioni sensoriali. Vi è poi l’olio di oliva lampante raffinato, prodotto attraverso processi chimici per correggere i difetti dell’olio vergine lampante che lo rendono non commestibile; ed esiste infine l’olio di sansa, estratto con solventi dalle sanse, i residui della lavorazione.
La denominazione di vendita è obbligatoria e deve essere coerente con le analisi chimico-fisiche e i test organolettici, inclusi i cosiddetti panel test, condotti da assaggiatori professionisti riconosciuti (International Olive Council).
Se un olio non supera questi controlli, ad esempio perché presenta note di rancido o acidità oltre i limiti, non può essere definito “extravergine” (si veda, Evaluation of minor components, sensory characteristics and quality of virgin olive oil by near infrared (NIR) spectroscopy, Food Research International). In tal caso, la normativa impone la riclassificazione e il ritiro dal mercato, con sanzioni anche gravi per chi etichetta impropriamente.
Frodi e sanzioni: il caso Carapelli e le ispezioni NAS
Il settore dell’olio d’oliva è uno dei più colpiti dalle falsificazioni alimentari. Le ragioni sono molteplici: l’elevato valore commerciale dell’olio extravergine, la difficoltà del consumatore medio nel valutarne oggettivamente la qualità e la complessità delle analisi necessarie a verificarne la conformità. A tutto ciò si aggiungono i margini di guadagno – talvolta elevatissimi – ottenibili con operazioni fraudolente ben orchestrate.
Uno dei casi più noti è quello che ha coinvolto Carapelli, marchio storico dell’olio italiano. Nel 2024, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di 230.000 euro per etichettatura ingannevole: l’olio presentato come extravergine non rispondeva ai parametri previsti dalla legge, mostrando caratteristiche chimiche e organolettiche proprie di un olio vergine (Olio Carapelli extravergine? Sanzione da 230 mila euro. L’azienda risponde – Il Fatto Alimentare).
Il caso Carapelli non è isolato. Secondo dati recenti, oltre il 27% degli oli etichettati come extravergine risulta non conforme ai test organolettici e chimici imposti dalla normativa (Olio extravergine: i controlli dei Nas rivelano truffe e frodi – Il Fatto Alimentare). In un’indagine condotta dai NAS e dall’ICQRF (Masaf – ICQRF – Ispettorato centrale repressione frodi), sono state sequestrate 180 tonnellate di falso olio extravergine sull’asse Puglia-Calabria, a riprova di un fenomeno che coinvolge non solo grandi marchi ma anche piccoli operatori della filiera (Truffa olio extravergine bio: sequestrate 180 tonnellate di prodotto contraffatto sull’asse Puglia-Calabria – Green Planet).
Le pratiche illecite più diffuse includono:
- la miscelazione di extravergine con oli di minor pregio;
- la deodorazione di oli difettosi per mascherare odori sgradevoli;
- l’uso di indicazioni geografiche fuorvianti, come l’evocazione dell’italianità su oli di provenienza estera;
- la falsificazione documentale relativa all’origine o alla campagna olearia.
In risposta a queste criticità, la normativa ha previsto una serie di strumenti di contrasto: obbligo di tracciabilità (rafforzato dalla piattaforma SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale), panel test riconosciuti, controlli a campione in stabilimento, analisi incrociate tra documenti fiscali e registri di produzione. In Italia, l’applicazione della legge n. 9/2013 ha avuto un ruolo centrale, introducendo sanzioni penali e amministrative specifiche per chi commercializza o etichetta impropriamente olio d’oliva.
Etichetta chiara, scelta consapevole
Leggere un’etichetta di olio extravergine d’oliva non è più – e non dovrebbe mai essere – un esercizio distratto. Dietro quella bottiglia si celano origine, metodi di produzione, controlli analitici e responsabilità legali che impattano sull’intera filiera, dalla raccolta delle olive al confezionamento.
Per orientarsi in modo consapevole, il consumatore dovrebbe prestare attenzione ad alcuni elementi chiave:
- Denominazione di vendita: “olio extravergine di oliva” non è un’espressione di marketing, ma una categoria legale definita da precisi requisiti normativi;
- Origine: l’indicazione è obbligatoria e deve specificare dove sono state raccolte le olive e dove sono state molite;
- Stabilimento di condizionamento: riconoscibile tramite il numero identificativo;
- Condizioni di conservazione: come “conservare al riparo dalla luce e dal calore”, che incidono sulla durata e sulla qualità reale del prodotto.
Attenzione anche alle diciture facoltative come “estratto a freddo”, “prima spremitura” o “campagna olearia”: sono termini regolati da criteri tecnici rigorosi e non possono essere usati arbitrariamente. Quando impiegati, devono riflettere caratteristiche oggettivamente riscontrabili, pena sanzioni per etichettatura ingannevole.
In un momento storico in cui la fiducia nei prodotti agroalimentari è messa alla prova da contraffazioni e informazioni ambigue, l’etichetta dell’olio d’oliva rappresenta un banco di prova per l’intera comunicazione alimentare. Non è solo una questione di trasparenza, ma di legalità, competitività e tutela della salute.
Bibliografia
International Olive Council. (2024, dicembre). Key-figures on the world market for olive oils (Dati adottati alla 120ª sessione del Consiglio)
ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. (novembre 2024). Rapporto 2024 sull’agroalimentare italiano
A.M. Inarejos-García, S. Gómez-Alonso, G. Fregapane, M.D. Salvador. Evaluation of minor components, sensory characteristics and quality of virgin olive oil by near infrared (NIR) spectroscopy, Food Research International, Volume 50, Issue 1,2013, Pages 250-258,ISSN 0963-9969, DOI:10.1016/j.foodres.2012.10.029
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – ICQRF. (2025). Report attività 2024
© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 25 Agosto 2025
È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.